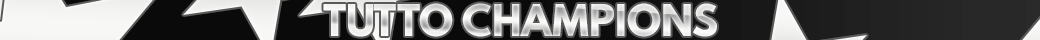Non accadeva dagli anni ’60, dalla doppia vergognosa uscita di scena in Cile prima e in Inghilterra poi: all’epoca, l’Italia fu condannata da una squadra incautamente chiamata da Ferruccio Valcareggi, supervisore del ct Edmondo Fabbri, un ‘gruppo di Ridolini’ di nome Corea del Nord e da un gol di tale Pak Doo-Ik, rimasto nella leggenda come ‘il dentista’ (che poi, a quanto pare, non era il suo vero lavoro). L’Uruguay uscito per mano della strepitosa Colombia non è certo una squadra di ‘Ridolini’ e Diego Godin non è uno che gioca a calcio per diletto ma un difensore vero, che ha regalato all’Atlético Madrid la Liga spagnola e per un soffio il suo gol non è valso la vittoria della Champions League. Resta il fatto che cambiando l’ordine dei fattori il risultato non cambia: azzurri a casa, come quattro anni fa in Sudafrica, e solo otto anni dopo aver alzato al cielo di Berlino la Coppa del Mondo. Un disastro, una Caporetto perpetrata negli anni.
Una sconfitta che brucia, fa ancora più male del morso subito da Giorgio Chiellini per bocca del vorace Luis Suarez. E che questa volta ha lasciato degli strascichi: polemici all’interno della squadra azzurra purtroppo, visti gli scambi di accuse che si sono verificati tra gli stessi giocatori del gruppo, messaggi e parole forse poco opportuni visto anche il momento. Ma anche pesanti sotto l’aspetto istituzionale, visto che, uno in fila all’altro, hanno rassegnato le loro dimissioni sia il commissario tecnico Cesare Prandelli sia il Presidente federale, Giancarlo Abete. Entrambi ammettendo le loro responsabilità e colpe e senza nascondersi dietro un dito, un’assunzione di colpe che non farebbe tanto clamore se non fossimo in Italia, con tutti i precedenti storici che ha vissuto questo Paese, sportivi e non.
Oltre all’inevitabile toto-ct scatenatosi sin dai primi minuti successivi all’annuncio da parte dell’ex allenatore della Fiorentina, è partita, puntuale come una tassa, anche il coro di accuse e controaccuse che puntualmente accompagna ogni insuccesso anche grosso della Nazionale o più in generale del nostro calcio: paghiamo l’arretratezza di un sistema che ormai non sta più al passo coi tempi, che non ha strutture adeguate; paghiamo la mancanza pressoché assoluta di stadi di proprietà, autentico motore della modernità calcistica, e stadi vetusti, scomodi e in certi casi anche pericolosi; paghiamo soprattutto la mancanza di una seria programmazione legata ai giovani, il continuo trascurare i vivai e i loro prodotti, spesso portati a emigrare anche nel bel mezzo della trafila delle giovanili in cerca di maggiore spazio, sacrificati sull’altare dell’esperienza o dello straniero pagato magari caro e che spesso si rivela un giocatore dannoso piuttosto che inutile. Paghiamo, soprattutto, un calcio troppo dipendente da una sola fonte: i diritti tv, che da soli pesano per oltre il 50% del fatturato di una società di Serie A.
Insomma, si discute di tutto questo, si prospettano e si auspicano novità e rivoluzioni, poi succede altro. Succede che il dibattito calcistico si impernia sulla querelle nata per l’assegnazione dei diritti televisivi per il triennio successivo alla prossima stagione, sulla diatriba tra i principali broadcaster a suon di comunicati, minacce di ricorsi ai tribunali, rischio di annullamento dell’asta, estenuanti assemblee di Lega per sbrogliare la matassa. Poi, arriva il dialogo, le tv fumano il calumet della pace, la questione si risolve (non è detto, visto che uno dei player esclusi dall’assegnazione penserebbe di adire le vie legali), e tutti si dichiarano felici, contenti e vincitori, prima fra tutte la Lega che da questo accordo incasserà poco meno di un miliardo di euro, soldi che rappresentano ossigeno puro per le casse dei club.
Ma proprio questo è il punto: è possibile che il sistema italiano non riesca mai a crearsi una nuova identità che non sia troppo legata ai proventi delle televisioni? Senza nulla togliere e senza accusare i protagonisti diretti di questo discorso, ma mentre nel resto d’Europa, dove comunque si guadagna tanto dalla trasmissione degli incontri, resistono e anzi fanno spesso assumono proporzioni importanti altri canali di ricavo come il merchandising e le biglietterie, in Italia da troppi anni si resta troppo attaccati al ricco carro delle televisioni. E’ un problema atavico, risalente addirittura a fine anni ’90, quando con la vendita individuale dei diritti i club hanno cominciato a chiedere sempre più risorse alle emittenti, riducendo al collasso il sistema televisivo e gonfiando una bolla poi evaporata in malo modo dopo anni di spese scriteriate e stipendi folli. Ed è un quadro che nemmeno la Legge Melandri, col ritorno alla vendita collettiva, non è riuscito a correggere fino in fondo, anzi ha dato adito in certe sue piccole lacune a dibattiti anche melliflui come quello legato ai ‘bacini di utenza’.
Ma soprattutto, è possibile che nel nome di qualche milione in più o in meno da strappare a questo o quel concorrente, magari da spendere solo per garantire un lauto stipendio a qualche semi-campione proveniente da chissà dove, si trascuri quella che è forse la cosa più importante, ovvero il lavorare tutti insieme per ripristinare dalle fondamenta l’arrugginito pallone italico? Ammiriamo tutti la Germania e il livello del suo campionato e della Nazionale di Loew, ma pochi forse sanno che i teutonici raccolgono i frutti di un vero repulisti generale, partito dal lavoro sui vivai e sui giovani tedeschi, un lavoro meticoloso (sono tedeschi…) e soprattutto fatto tutti insieme che oggi ha portato la Germania al livello che tutti vediamo.
E mentre anche altri Paesi come il Belgio e, attenzione, anche gli Stati Uniti dove la Mls sta crescendo esponenzialmente in importanza, stanno raccogliendo i frutti di un vero processo di ri-alfabetizzazione calcistica, in Italia si resta ancora fermi al palo, e ogni progetto formale o ipotizzato di riforma dalle basi finisce in un cassetto destinato a finire vittima delle ragnatele. E i giovani dei vivai una volta conclusa la formazione o sono bravi davvero o sono destinati a smarrirsi, gettati alla carlona nella mischia senza un sistema che ne agevoli il lancio nel mondo dei grandi. Mortificando magari il lavoro di club che nel settore giovanile investono ogni anno risorse e fondi e vantano anche picchi di eccellenza come l’Inter. Lavorare tutti insieme per capire i mali da curare del calcio italiano; è un po’ anche un discorso toccato da Erick Thohir, presidente nerazzurro. Tanti lo dicono, ma nessuno ha mai preso davvero il discorso, troppo impegnato a curare l’interesse particolare. Di queste cose si parlava già quattro anni fa dopo l’uscita dal Mondiale sudafricano; quanto tempo ancora, allora, dovrà passare?
Altre notizie - Editoriale
Altre notizie
- 00:08 Milojevic (all. Stella Rossa): "Fallo netto sul secondo gol del Milan, una vergogna. Arbitro arrogante e col sorriso in faccia"
- 00:03 Ancora Fonseca: "Sono triste e non mi fermerò. Disposto a portare i ragazzi della Primavera o del Milan Futuro se servirà"
- 00:00 I danni del turnover scientifico
- 23:55 Fonseca: "Questo Milan è una montagna russa, oggi stai bene e domani non lo sai. E' impressionante"
- 23:40 City a picco, Guardiola: "Complimenti alla Juve, ci manca compattezza". E la prossima è contro il Psg
- 23:27 Pandev: "L'Inter non meritava di perdere, questo è il calcio. Mancano due partite e devi fare 6 punti"
- 23:12 Commissione sul caso ultrà, Verini: "Vogliamo ascoltare innanzitutto i vertici dello sport italiano e delle società calcistiche"
- 22:59 Capolavoro Juve, 2-0 al City. Pari Bologna, Abraham salva il Milan nel finale. Risultati e classifica: Inter sesta
- 22:44 Primavera 1, Vogliacco dirigerà Atalanta-Inter: fischio d'inizio sabato alle ore 13
- 22:30 A. Paganin: "Ci sta non avere serate brillanti col Leverkusen. Ma se l'Inter fa così a Roma..."
- 22:16 Renica: "Lukaku all'Inter si esprimeva bene con Lautaro. Al Napoli potrebbe farlo con Simeone"
- 22:02 Tonali ha nostalgia dell'Italia? L'agente Riso smentisce: "E' felice in Premier, al Newcastle è un idolo dei tifosi"
- 21:48 Vicenza, Cester ricorda: "A 14 anni andai all'Inter, vincemmo due campionati. E con Casadei..."
- 21:34 La convinzione di Mandorlini: "Scudetto, l'Atalanta sarà in corsa fino alla fine"
- 21:20 Napoli, Gilmour: "C'è voglia di essere positivi nonostante la sconfitta. Troveremo risultati migliori"
- 21:06 Man. City, altra finale di Champions dopo Istanbul? Guardiola: "Se passiamo il turno, non sarà facile per nessuno incontrarci"
- 20:52 UCL - Nove gol nelle due partite delle 18:45: vincono Atletico e Lille. Francesi a 13 punti come l'Inter, Simeone a -1
- 20:37 Barzagli: "Scudetto? Inter davanti a Napoli e Atalanta. Ma la Juve..."
- 20:23 L'Urawa Red Diamonds conferma Skorza allenatore: "Vogliamo diventare un club che compete nel mondo"
- 20:10 Mondiale per Club 2025, il Congresso straordinario FIFA ha approvato i principi di bilancio: la nota ufficiale
- 19:55 Primavera 1, fissati orari delle prime gare del 2025: le date di Juve-Inter e della Coppa Italia
- 19:40 Accademia Inter, Bergomi resta alla guida dell'U17 Elite: "Però chiedo rispetto"
- 19:27 Lazio, Baroni: "Contiamo di recuperare Vecino e Romagnoli per l'Inter"
- 19:14 Youth League, il 20 dicembre il sorteggio dei sedicesimi di finale: le 6 avversarie potenziali dell'Inter
- 19:00 Rivivi la diretta! TAREMI e FRATTESI i più criticati, ACERBI ora è un CASO da risolvere: l'INTER va sul MERCATO?
- 18:45 Ranking UEFA, Italia in affanno per il quinto posto Champions: Inghilterra e Portogallo davanti
- 18:30 Cagliari-Inter, da domani in vendita i biglietti ma il settore ospiti rimane in stand-by
- 18:16 Gabigol saluta il Flamengo: "Qui sono diventato immortale, un giorno tornerò". Poi attacca la dirigenza
- 18:02 Sofascore, Team of the Week Primavera - De Pieri unico interista, il 30 di Zanchetta primeggia nel voto
- 17:50 Youth League, Inter da record: è la quarta squadra nella storia a fare 6 vittorie su 6 partite nel girone
- 17:35 Gli USA casa del Mondiale per Club? La FIFA potrebbe portare negli States anche l'edizione 2029
- 17:22 Voce al tifoso - Commenti dopo la brutta serata di Leverkusen
- 17:07 UFFICIALE - Assegnati i Mondiali 2030 e 2034: l'edizione del centenario in sei Paesi, poi l'Arabia Saudita
- 16:54 Il Milan U20 perde ancora e saluta definitivamente la Youth League: ko al Vismara per 1-3 contro la Stella Rossa
- 16:39 Balzaretti: "Zero tiri in porta è un dato negativo importante. Taremi in fase involutiva"
- 16:25 Palladino non convoca Biraghi per il LASK. L'agente non ci sta: "Capitolo Firenze finito. A gennaio andrà via"
- 16:10 fcinBetsson Sport, in agenda nuove attività: quiz per i tifosi, una replica e una sfida contro... Francesco Totti!
- 15:57 Qui Lazio - Tre assenti ad Amsterdam: oltre a Romagnoli e Vecino, anche Provedel resta a Roma. Il punto
- 15:43 Gasperini: "Dobbiamo capire che l'Atalanta può giocarsela con squadre come Real e Inter"
- 15:28 Spalletti: "Le scelte per le prossime convocazioni rimarranno quelle già fatte". Poi loda due rivali dell'Inter
- 15:14 Ascolti 15esima giornata Serie A, Inter-Parma meglio di Atalanta-Milan su DAZN
- 14:59 L'analisi di Hodgson: "Inter ben organizzata ma il Bayer ha meritato. Frimpong a tratti immarcabile"
- 14:45 GdS - Tonali, nostalgia Italia: lui desidera il Milan, anche Inter e Juventus stuzzicate
- 14:30 Retroscena GdS - Nel 2021 il fondo PIF tentò l'acquisto dell'Inter: offerta bocciata da Steven Zhang
- 14:15 Angolo Tattico di Bayer- LeverkusenInter - Le linee troppo schiacciate dietro, l’iniziativa lasciata ai tedeschi, gli attaccanti isolati
- 14:05 Inchiesta Curve, il Riesame non transige: "Clima di terrore attorno al personale dell'Inter". Le ordinanze di Zaccagni e Nepi
- 13:52 Tigani: "Alte motivazioni anche a qualificazione ottenuta. Vogliamo sempre dare il massimo"
- 13:38 Centocinquanta volte idolo neroblu. Nella sua Leverkusen, Calhanoglu timbra la presenza numero 150
- 13:30 Inzaghi in mista: "A livello offensivo abbiamo fatto poco, ma anche il Bayer. Un punto sarebbe servito, ma..."
- 13:23 Condò non fa drammi: "Il punto perso col Bayer dall'Inter non è un problema"
- 13:12 Bologna-Milan rimandata per maltempo. I rossoneri fanno ricorso: "Decisione di Lepore iniqua e illegittima"
- 13:05 M. Zanchetta: "L'abbraccio con papà dopo il gol? Migliorato molto come giocatore, lo ringrazio tanto"
- 12:55 Inter batte Bayer in Youth League, Runge (all. Leverkusen): "Loro molto forti, sono orgoglioso dei miei ragazzi"
- 12:42 Lavelli: "La Youth League ci ha aiutati a crescere. L'obiettivo è arrivare in fondo in Europa e in campionato"
- 12:28 Problemi tecnici in aeroporto, notte tribolata per l'Inter: la squadra è rientrata solo oggi a Milano
- 12:14 Mukiele letale per l'Inter, la Uefa lo elegge MVP. Il difensore: "Abbiamo sempre creduto nel gol"
- 12:05 Serie A, arbitri 16esima giornata: Lazio-Inter affidata a Chiffi di Padova, al VAR ci sarà Mazzoleni
- 12:00 INTER RINUNCIATARIA a LEVERKUSEN ma nulla è COMPROMESSO. Quanti PUNTI per gli OTTAVI? Allarme ACERBI
- 11:53 Sommer recrimina: "Partita equilibrata, alla fine la fortuna ha sorriso al Leverkusen"
- 11:45 Cambiasso: "L'Inter è stata poco ambiziosa. Il ko col Bayer non complica nulla, ma è un passo indietro"
- 11:37 Lautaro fa 300 presenze con l'Inter, il club lo celebra sui social
- 11:30 Boban avvisa l'Inter: "Questa sconfitta non è un disastro, ma serva da insegnamento. Ecco perché"
- 11:20 Bisseck a DAZN Deutschland: "Siamo stati troppo passivi, il Bayer ci ha stressati. Nulla meglio della UCL"
- 11:16 Xhaka: "Vittoria meritata del Bayer, l'Inter non ha quasi mai tirato"
- 11:02 Moviola CdS - Disastro arbitrale: Vincic s'inventa due ammonizioni per gli interisti e il gol nasce da un fuorigioco non segnalato
- 10:48 Pagelle CdS - Troppi errori per Bastoni, Calhanoglu concede respiro
- 10:34 Trevisani: “Inzaghi via dall’Inter? Lo vedo solo in un altro club. Dimarco più forte di Theo, ma fino a tre anni fa…”
- 10:20 Bisseck il filosofo: "Questo finale amaro contro il Leverkusen bilancia le volte in cui abbiamo avuto fortuna"
- 10:06 TS - Arnautovic, c'è l'offerta dal Torino: ecco la cifra messa sul tavolo
- 09:52 Capello: "Dopo i cambi a centrocampo col Bayer, Inzaghi farà meno esperimenti in futuro"