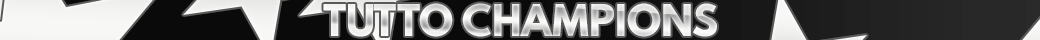Forte dei Marmi, estate 1960. Uno sconsolato Angelo Moratti s'interroga su quel che sarà della sua Inter. Il patron della Saras ha fatto diventare il club nerazzurro un bene di famiglia cinque anni prima, prelevando le quote societarie da Carlo Masseroni. I risultati, del resto, non sono arrivati: otto allenatori dal contributo sterile (nessun titolo agguantato), con la continua esigenza di affidare la squadra a stagione in corso all'ex goleador Giuseppe Meazza, il quale - da buon discepolo di Pozzo - ha fatto valere le proprie doti di motivatore e gestore di risorse umane provvedendo a limitare i danni in termini di risultati sportivi.
Moratti rende grazie al due volte Campione del mondo, ma - dal canto suo - vuole vincere lo Scudetto. Forse l'avrebbe già fatto se nel '58 non fosse stato costretto a stracciare il contratto che legava ai meneghini un giovanissimo Pelé, reduce dal Mondiale svedese nel quale aveva istituito la sacralità della maglia numero 10 nel calcio: a Rio de Janeiro il clima era tesissimo e addirittura i tifosi del Santos mandarono a fuoco la sede societaria, cosicché Moratti si fece un buon esame di coscienza e fece restare al Maracanã quello che sarebbe stato poi dichiarato Patrimonio Nazionale del Brasile. È il più grande rimpianto della storia dell'Inter, visto che O Rey aveva già firmato. Ma con i brasiliani, nel 1958, è meglio non scherzare.
Il presidente dei nerazzurri si ritrova, a tal punto, dinnanzi a una scelta: sfumato il miglior giocatore del mondo, non ripagata la fiducia data a molti tecnici, quale altra scelta è necessaria per poter alzare un trofeo? Facile, si direbbe: l'allenatore più quotato d'Europa è un argentino naturalizzato francese, da giocatore ha riscosso risultati modesti ma in panchina è un rivoluzionario. Ha spodestato il Real Madrid dal trono di Spagna (già: "quel" Real Madrid, di Puskas e Di Stefano), allenando un Barcellona fluido nelle ripartenze ed efficace in proiezione offensiva. Trovare l'accordo con lui non è semplice: oltre a un ingente stipendio, vuole anche che gli sia concesso di guidare la Nazionale spagnola fino al Mondiale del '62 (e vincerà qualcosa con l'Inter soltanto dopo aver allenato le Furie Rosse nella kermesse cilena). Non è un personaggio controverso: di più. Ma Angelo Moratti gli consegna le chiavi dell'Inter e lui la fa volare. Anzi, la fa diventare Grande. Per sempre. Quell'uomo si chiamava Helenio Herrera. Lui, forse, di un'effimera presentazione ha bisogno. La sua bacheca, no.
Di anni ne son passati, di mezzo c'è stato un Triplete ma la storia è la stessa: il gruppo Suning entra nel mondo Inter convinto di poter riportare il blasone del club ai fasti di un tempo, dopo un primissimo anno in cui prende le misure con la dimensione societaria si affida a Luciano Spalletti per rivedere le stelle della Champions League e alla fine, quando deve compiere il grande passo per iniziare a diventare "grande", la scelta ricade su Antonio Conte. Re di Londra, eroe bianconero, vice-campione del mondo a Usa '94 con la Nazionale di Sacchi. Uomo del Sud che ha fatto le sue fortune al Nord e che in seguito ha unito Settentrione e Meridione alla guida della sua Italia (che fin troppo bene ha figurato visto il materiale tecnico a disposizione). A Lecce è cresciuto nella via che porta il nome di Giuseppe Parini, anti-sistema al suo tempo. E lui, come gli è stato richiesto, dovrà far vacillare le vecchie impalcature del calcio italiano tentando di farle cadere, in modo da far tornare la facciata del palazzo più bello - quello nerazzurro - a risplendere ed essere ammirata da tutti.
Conte è un maniaco della perfezione, è ossessionato dal risultato: sua figlia, per dovere di cronaca, si chiama Vittoria. Il trionfo: un sogno, ma anche un obiettivo concreto. Per raggiungerlo è necessario lavorare sulle menti dei giocatori. "Prima ti alleno la testa, poi ti alleno le gambe". Questa frase, ad Appiano, si era già sentita. Perché l'importante, nel calcio, è rendere al massimo. "Chi non dà tutto, non dà niente", riferiva il Mago. Conte, senz'altro, è dello stesso avviso. Così come Herrera, il tecnico salentino ha sempre fondato le sue squadre su una difesa solidissima e sul gioco in verticale. Fondamentale è convincere i propri uomini che essi possano andare oltre ogni limite: vincoli e paure, nella sfera di Conte, sono soltanto illusioni. Il 27 maggio 1965, pochi istanti prima della finale di Coppa dei Campioni contro il Benfica, Herrera ribadì ai suoi che un certo Eusébio da Silva Ferreira (circa 500 reti in carriera) fosse limitato tecnicamente. Bedin scese in campo e, forte di uno stato mentale ideale, gli si attaccò riuscendo a non fargli toccare palla. Un ragionamento non troppo lontano da quello che ha portato nel 2016 Daniele De Rossi a rifilare un tunnel ai danni di Andrés Iniesta nel trionfo azzurro di Saint-Dénis contro la Spagna.
Helenio Herrera ed Antonio Conte: cinquant'anni di distanza, ma filosofie molto simili tra di loro. Menti geniali, spiriti battaglieri, DNA da vincenti. Entrambi fautori di due sistemi discussi, ma terribilmente efficaci. L'uno ha fatto le fortune dell'Inter negli Anni '60 guidando una delle formazioni più poetiche di sempre, l'altro spera adesso - grazie al supporto della società, della squadra e alle sue capacità di gestione - di poter avviare un percorso fondato su un progetto solido e volto alla conquista di nuovi titoli. Per riportare, finalmente, l'Internazionale dove merita.
Autore: Andrea Pontone / Twitter: @_AndreaPontone
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 23:55 Como tra Roma e Inter, Fabregas: "Vogliamo prendere punti anche dove è difficile"
- 23:41 videoNapoli, rimonta di rabbia e Udinese ribaltata: finisce 3-1. Gli highlights
- 23:26 Di Francesco mastica amaro e ripensa all'Inter: "Questa mano ci sta rovinando le trasferte con le big"
- 23:12 Adriano riabbraccia Materazzi, foto insieme per i due grandi ex nerazzurri: "Felice di vederti"
- 22:57 Domani alle 12.30 l'Inter Women ospita il Sassuolo: sono 25 le convocate di Piovani
- 22:44 La Juve vede le streghe, Vlahovic la salva dal dischetto: il Venezia sfiora il colpo ma è 2-2
- 22:29 Udinese, Zemura: "Resettiamo questa gara col Napoli, giovedì abbiamo l'Inter in Coppa"
- 22:15 Piccoli (?) leader crescono: quello spirito da capo carismatico di Bastoni che va oltre le sue dichiarazioni
- 22:02 Abodi garantisce: "Valutiamo il ripristino della pubblicità del betting in tempi brevi"
- 21:48 Napoli, Anguissa: "Concentrati su di noi, dobbiamo ricordarci di essere una grande"
- 21:33 Gli auguri dell'Inter per gli 84 anni di Ernesto Pellegrini, il presidente dello Scudetto dei record
- 21:19 Lazio, Baroni salta la conferenza stampa della vigilia del match contro l'Inter
- 21:04 Atalanta, Kolasinac: "Lo Scudetto? Andiamo avanti, ora non è importante pensarci"
- 20:49 Brest, Rey e la stoccata alla UEFA: "La sua volontà è il denaro fine a se stesso"
- 20:35 Pecchia: "La partita contro l'Inter è uno spunto su cui lavorare. Ma il percorso va fatto su noi stessi"
- 20:21 Torino, Cairo: "Arnautovic? Non faccio nomi, ma sicuramente interverremo sul mercato"
- 20:07 Il Napoli reagisce e sbanca Udine: tris in rimonta, Conte a due lunghezze dall'Atalanta
- 19:52 Sky - Ballottaggio in difesa in vista della Lazio: Darmian contende una maglia a Bisseck
- 19:38 Hamann fa mea culpa su Sommer: "È uno dei migliori portieri d'Europa in questo momento"
- 19:37 Altobelli: "Vi racconto la mia Inter. Lautaro? Può superarmi nella classifica marcatori"
- 19:23 Ghidotti superstar nel derby Samp-Spezia: finisce 0-0, anche Pio Esposito sbatte sul portiere blucerchiato
- 19:10 Simeone, lode all'Inter: "Non ha una stella ma tanti giocatori importanti. Mi piace molto, come il Barcellona"
- 18:44 AIA, eletto il nuovo presidente: è Antonio Zappi. Battuta la candidatura di Trentalange
- 18:29 Udinese, Inler: "Sanchez ha sofferto, voleva rientrare. Offerte Bijol? Ora siamo concentrati sul match"
- 18:15 Sky.de - Inter sul talentuoso centrocampista Reitz: tra clausola e pressing del Brighton
- 18:00 Caressa: "Fonseca ha polemizzato dopo Atalanta-Milan senza informare la società, questo non è piaciuto. Manca un leader"
- 17:45 Napoli, Conte: "Siamo all'inizio della costruzione. Sanchez incredibile, gli auguro il meglio"
- 17:30 Atalanta, Gasperini: "Dieci vittorie di fila, ma non cambia niente. Ci sono anche gli altri"
- 17:15 Un 2024 da paura, Thuram coinvolto in 20 gol nella Serie A: nessuno ha fatto meglio di lui. E non è ancora finita...
- 17:00 Serie A, all'Atalanta basta Zaniolo: 1-0 sofferto al Cagliari e balzo a +6 sull'Inter
- 16:45 Bastoni a quota 3 assist in campionato, è già record. Calhanoglu una garanzia contro la Lazio
- 16:30 Atalanta-Inter, Up&Down - Dal vangelo secondo i... Matteo: che partita di Venturini e Spinaccé. Una sola la nota stonata
- 16:15 videoFerri: "Nello sport passione e formazione sono importanti. I genitori devono dare l'esempio"
- 16:00 videoMarotta: "Lo sport è una palestra di vita. Ai giovani dico di divertirvi e crescere per essere gli uomini del domani"
- 15:45 Inter letale in area di rigore, 32 reti segnate: nessuno ha fatto meglio. E Sommer non ha mai subito gol dalla distanza
- 15:30 videoBove al Viola Park, visita ai compagni di squadra. Applausi e sorrisi: il gol più bello di Edoardo
- 15:15 Atalanta, D'Amico: "Pressioni su di noi? Sono motivazioni. Ci faremo trovare pronti per il mercato di gennaio"
- 15:00 Occasione speciale per Lautaro, feeling particolare con la Lazio e l'Olimpico: i numeri
- 14:53 Gara a senso unico ad Alzano: l'Inter U20 fa la voce grossa e stende con un tris l'Atalanta
- 14:45 Fonseca è incontenibile: "Ho parlato con chi volevo parlare. Domani in campo qualcuno di Milan Futuro"
- 14:30 Simone Inzaghi, re delle coppe e del... lunedì: filotto di 5 vittorie consecutive. E contro Baroni non ha mai perso
- 14:15 Lazio-Inter, lunedì all'Olimpico la sfida numero 163 in Serie A: i precedenti. Terza sfida di lunedì nella storia
- 14:00 Assemblea generale AIA, il presidente uscente Pacifici: "Ho fatto errori, ma siamo in ottima salute. Fatevene una ragione"
- 13:45 Assemblea generale AIA, Gravina: "La FIGC ha tutto l’interesse che sia forte e autonoma. Noi al fianco degli arbitri"
- 13:30 Torino, Cairo: "Derby persi con la Juve? Prima del VAR ce ne hanno rubati non pochi. Sul futuro del club..."
- 13:15 Sky - Inzaghi a Roma senza sorprese ma con soluzioni di fantasia. Darmian candidato alla panchina ecco perché
- 12:55 Dopo aver lasciato l'ospedale, Bove corre dai compagni. Il giocatore atteso oggi al Viola Park
- 12:40 GdS - Acerbi, l'Inter riflette: scatterà la risoluzione unilaterale? Intanto De Vrij va alla grande
- 11:57 Un altro premio per Marotta: riconoscimento da parte dell'AIAC Siena
- 11:42 Parolo: "Inzaghi tra i migliori al mondo. Inter, entrare tra le prime 8 di UCL è un dovere"
- 11:27 Marotta: "Inter, famiglia di grandi valori. Non siamo i più bravi, ma i più ambiziosi". Poi l'augurio particolare
- 11:08 Zaccheroni: "Dal 5 maggio a Moratti: bello e appassionante per me che tifavo Inter. Un nome? Stankovic"
- 10:53 TS - Prove anti-Inter per Baroni. L'allenatore della Lazio con un solo vero grande dubbio
- 10:37 TS - La rivalsa dopo Leverkusen. Inzaghi all'Olimpico non vuole errori e punta tutto sulla ThuLa
- 10:23 Peruzzi: "Anno deludente all'Inter, mi fa ridere il gioco dal basso. Calciopoli? Non discuto le sentenze, ma Moggi..."
- 10:06 Dumfries: "All'Inter siamo un bel gruppo. Rissa in Olanda-Argentina? Perdo raramente il controllo, l'ho imparato facendo kick boxing"
- 09:52 Ancora Dumfries: "Raiola uomo dolce. Fin da piccolo avevo un sogno..."
- 09:38 Dumfries: "La chiamata di Ausilio e quel primo giorno particolare ad Appiano. Sulla differenza tra campionato e Champions..."
- 09:24 CdS - Scontri diretti: bilancio insoddisfacente. Inzaghi punta la Lazio
- 09:10 GdS - Difesa obbligata, poi tanti cambi: la probabile di Inzaghi
- 08:56 GdS - Niente da fare: per Bastoni, Dimarco e Barella c'è solo l'Inter. Molteplici no ai tentativi delle big di Premier League
- 08:42 CdS - Inzaghi ne cambia cinque, Dumfries fondamentale: la probabile formazione
- 08:28 Inzaghi: "Vincere è difficile, rivincere di più. Ma ho una convinzione"
- 08:14 Marotta alla festa di Natale: "Vogliamo successi nel rispetto della sostenibilità. Ambizione senza arroganza"
- 08:00 AIA, Zappi punta alla presidenza: "Dialoghi VAR pubblici come nel rugby. E sono favorevole al challenge"
- 00:17 Ventola: "In Champions proverei ad alzare il ritmo schierando i titolari"
- 00:01 Ci vorrà una gara olimpica