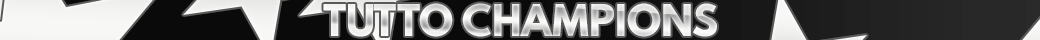Non è più possibile ormai esimersi dall’infausto compito: non è stato possibile ieri e allora toccherà adesso affrontare quello che giocoforza è ormai diventato il tema nazional-popolare delle ultime ore, ovvero il cataclisma verificatosi lunedì sera allo stadio di San Siro. Dove è arrivata la sentenza che nessuno, se non altro per amor patrio, avrebbe mai avuto il coraggio di pronosticare per non dire di immaginare: quando in Russia, il prossimo 14 giugno, sarà battuto il calcio d’inizio del Mondiale 2018, l’Italia non ci sarà. Dopo sessant’anni, gli azzurri mancheranno l’appuntamento con la kermesse iridata: carnefice degli azzurri è stata la Svezia, ancora la Svezia che si diverte a recitare il ruolo della coprotagonista nelle pagine più nere della storia dell’Italia calcistica (l’ultimo Mondiale non disputato si giocava proprio lì, come anche l’ultimo Europeo dove siamo stati assenti, per tacere del 2004…). La Svezia che capitalizza al meglio il fortunoso gol di vantaggio dell’andata, resiste in trincea per novanta e passa minuti, e alla fine esplode in una grande festa con tanto di devastazione del palchetto della tv nazionale posto a bordo campo.
Si può disquisire a lungo della partita, dell’approccio al playoff da parte di questa Nazionale, delle scelte a tratti cervellotiche operate dal ct Gian Piero Ventura, di quanto possano essere nefasti gli scenari futuri. Quello che rimane vivo e che brucerà ancora per parecchio tempo è che i 72mila presenti al Giuseppe Meazza e gli oltre 15 milioni di italiani che hanno seguito il match davanti alla tv, al triplice fischio dell’arbitro Antonio Miguel Lahoz, sono rimasti lì, impietriti, testimoni di una realtà che sembrava lontana anche nel peggiore degli incubi: l’Italia fuori dal Mondiale, gli italiani che perdono un giro nell’evento che segna irrimediabilmente le vite di tutti noi, anche quelli che magari al calcio guardano in maniera un po’ snob. Non ci saranno estati in piazza, meeting con gli amici, feste o lacrime collettive, caroselli o mesti rientri, notti magiche che tengano: svanirà anche la vena romantica che circonda quel mese a tutto pallone. E considerando che nel 2022 il Mondiale sarà giocato nei mesi invernali, in un’atmosfera insolita e per certi versi anomala, si avverte la sensazione di un racconto appassionante da scrivere ma che ti ritrovi costretto a interrompere malamente, perché l’inchiostro si è esaurito e nessuno si è accorto che andava fatta la ricarica.
Perché bisogna ammetterlo: nessuno pensava che peggio di quanto avvenuto nelle ultime due edizioni dei Mondiali, con le sciagurate eliminazioni nei gironi, potesse avvenire. Eppure, quelle due figure barbine, al cospetto di avversari di certo non di primissimo piano come Nuova Zelanda, Slovacchia o Costa Rica, rappresentavano indubbiamente due campanelli d’allarme da non sottovalutare. E i due buoni Campionati Europei disputati successivamente altro non sono stati che delle foglie di fico che alla lunga non hanno saputo mascherare i problemi, esplosi in maniera fragorosa nell’infausta serata meneghina. Dopo la quale, è inevitabilmente partita la caccia all’untore, la corsa a dare la spiegazione più o meno logica a questo disastro e a dettare, anche da alti scranni, eventuali rimedi da somministrare al malato di lungo corso, che però ormai assumono i toni di cure caritatevoli.
Nel 2010, chiusa amaramente l’esperienza sudafricana, l’unica decisione di rilievo presa come soluzione per tutti i mali del calcio è stata la limitazione dei tesseramenti di nuovi giocatori extracomunitari limitandoli ad uno solo per squadra; una manovra risibile e sconfessata prontamente poco dopo. Adesso, si punta l’indice sui vivai, sul fatto che anche le selezioni giovanili siano ormai infarcite di giocatori stranieri, invocando un maggiore protezionismo nei confronti del talento nostrano. Valutazioni, queste, che magari potevano andare bene (ma nemmeno tanto...) in un sistema come quello del blocco del 1966, ma che ormai rasentano la sfera demagogica (tant’è vero che vengono usati anche per fomentare il dibattito politico…). Perché, al di là del fatto che in ambito sportivo il fatto di inserire regole e regoline su numero minimo di giocatori locali hanno portato generalmente più problemi che vantaggi, ormai il sistema mondo si è talmente evoluto da non dare più nemmeno un senso alla valorizzazione solo in base al passaporto. Anche perché il concetto stesso di Nazionale a livello giovanile è stato svilito dai regolamenti recenti, con un ragazzo che può fare tutta la trafila con una maglia e poi, una volta fatto il salto tra i grandi, scegliere di vestire un’altra casacca qualora ne abbia la possibilità; senza contare che qualcuno più furbo degli altri potrebbe anche appellarsi al concetto di ‘italiano di formazione’, peraltro già contemplato dalle normative, con eventuali conseguenti beghe tecniche e via cantando.
In Germania o in Spagna, tanto per citare gli esempi delle ultime Nazionali trionfanti, problemi di questo tipo non ce ne sono, anzi gli stranieri abbondano, eppure le vittorie degli ultimi tempi danno loro ragione. E anche in Inghilterra, lì dove la Premier League pullula di giocatori non inglesi, le selezioni giovanili stanno facendo man bassa di trionfi internazionali. Perché? Forse, diciamo forse, per via di programmi di formazione efficaci, di un management abile e lungimirante che ha saputo trarre soluzioni eccellenti per uscire dai momenti di gravi crisi sapendo guardare anche e soprattutto al lungo termine, di un sistema che ha saputo davvero curare gli aspetti formativi (e qui tutto è raccontato in soldoni). In Italia qualcosa si è mossa solo di recente con l’apertura dei nuovi Centri federali per la formazione dei calciatori, sicuramente un’iniziativa lodevole della quale però vedremo i frutti solo fra qualche anno. Ma nel frattempo, oltre alla quantità, si cominci a curare la qualità, intesa come qualità della formazione dove al primo posto venga messo il talento, il gioco, perché no anche il divertimento, prima ancora di cominciare ad analizzare gli aspetti tattici ormai esasperati anche tra i ragazzini.
Ma come si deve lavorare dal basso, si deve lavorare, e molto, anche dall’alto: a questo Paese serve disperatamente un nuovo gruppo di dirigenti capaci, con idee chiare e innovative, che possa rompere definitivamente gli schemi del passato ancora perpetrati all’interno del sistema sportivo nazionale. E questo è un discorso che non può riguardare soltanto il calcio. Perché, pensandoci bene, quello degli azzurri del calcio non è che l’ultimo di una serie di flop che ha già coinvolto buona parte del nostro sport. Giusto per fare qualche esempio: la pallacanestro, dopo il periodo splendido culminato con l’argento olimpico di Atene, è sparita di scena; la pallavolo e la pallanuoto, solo due decenni fa vanto sportivo globale, stentano da anni vivendo di effimere folate; spostandoci agli sport individuali, mentre resiste la tradizione della scherma e si difende il nuoto, l’atletica vive anni di vacche magre e anche nel ciclismo i risultati a livello di Nazionale latitano dopo periodi anche recenti di continui allori. Insomma, la necessità di cambiamento è globale.
Magari bisogna anche sconvolgere quello che è l’aspetto finanziario, come fatto per esempio dalla Gran Bretagna che, specialmente dopo il disastro dei Giochi Olimpici di Atlanta 1996, ha messo mano pesante alla questione sportiva e alla redistribuzione delle risorse inerenti, creando (anche qui, estrema sintesi) un nuovo sistema basato sui fondi della lotteria nazionale e dove il primo criterio per avere i ‘dindi’ è quello del merito, dei risultati effettivi e soprattutto potenziali. Col risultato che dal 2000 in avanti Madama Albione ha vissuto un’escalation continua col boom di Rio 2016 e del secondo posto nel medagliere olimpico. Un sistema agli antipodi rispetto alle abitudini italiche, dove gli equilibrismi politici la fanno spesso e volentieri da padrone, che magari potrebbe fare inorridire qualche benpensante, ma semplicemente un esempio di quello che serve all’ecosistema sportivo nazionale per destarsi come recita l’inno di Mameli: basta fioretto, forse ora serve la sciabola.
Serve soprattutto far rinascere lo sport, e riconsegnarlo ai suoi veri protagonisti e allontanarlo da trame extracampo, interessi di affaristi, procuratori ed eminenze grigie di varo genere; uno sport, insomma, dove si torni a vincere perché alla fine è solo un gioco. Sarebbe una rivoluzione, appunto: uno spettro, più che una parola, visto aleggiare con terrore e che si prova ormai a scacciare con ogni mezzo, e chi se ne importa se poi alla fine i risultati sono questi… E riecheggiano lontane le parole del maestro Franco Battiato e della sua ‘Povera Patria’. D’accordo, forse affidarsi spesso alla musica alla lunga può diventare stucchevole e i temi toccati nel testo sono decisamente più pesanti di quello sportivo. Ma sarà legittimo porsi un quesito: e se il declino dello sport di squadra italiano non fosse altro che una faccia di un Paese che ormai da tempo ha perso l’abilità, financo il gusto, di fare squadra?
No, non cambierà. Forse cambierà. La primavera intanto tarda ad arrivare.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Editoriale
Altre notizie
- 23:55 Como tra Roma e Inter, Fabregas: "Vogliamo prendere punti anche dove è difficile"
- 23:41 videoNapoli, rimonta di rabbia e Udinese ribaltata: finisce 3-1. Gli highlights
- 23:26 Di Francesco mastica amaro e ripensa all'Inter: "Questa mano ci sta rovinando le trasferte con le big"
- 23:12 Adriano riabbraccia Materazzi, foto insieme per i due grandi ex nerazzurri: "Felice di vederti"
- 22:57 Domani alle 12.30 l'Inter Women ospita il Sassuolo: sono 25 le convocate di Piovani
- 22:44 La Juve vede le streghe, Vlahovic la salva dal dischetto: il Venezia sfiora il colpo ma è 2-2
- 22:29 Udinese, Zemura: "Resettiamo questa gara col Napoli, giovedì abbiamo l'Inter in Coppa"
- 22:15 Piccoli (?) leader crescono: quello spirito da capo carismatico di Bastoni che va oltre le sue dichiarazioni
- 22:02 Abodi garantisce: "Valutiamo il ripristino della pubblicità del betting in tempi brevi"
- 21:48 Napoli, Anguissa: "Concentrati su di noi, dobbiamo ricordarci di essere una grande"
- 21:33 Gli auguri dell'Inter per gli 84 anni di Ernesto Pellegrini, il presidente dello Scudetto dei record
- 21:19 Lazio, Baroni salta la conferenza stampa della vigilia del match contro l'Inter
- 21:04 Atalanta, Kolasinac: "Lo Scudetto? Andiamo avanti, ora non è importante pensarci"
- 20:49 Brest, Rey e la stoccata alla UEFA: "La sua volontà è il denaro fine a se stesso"
- 20:35 Pecchia: "La partita contro l'Inter è uno spunto su cui lavorare. Ma il percorso va fatto su noi stessi"
- 20:21 Torino, Cairo: "Arnautovic? Non faccio nomi, ma sicuramente interverremo sul mercato"
- 20:07 Il Napoli reagisce e sbanca Udine: tris in rimonta, Conte a due lunghezze dall'Atalanta
- 19:52 Sky - Ballottaggio in difesa in vista della Lazio: Darmian contende una maglia a Bisseck
- 19:38 Hamann fa mea culpa su Sommer: "È uno dei migliori portieri d'Europa in questo momento"
- 19:37 Altobelli: "Vi racconto la mia Inter. Lautaro? Può superarmi nella classifica marcatori"
- 19:23 Ghidotti superstar nel derby Samp-Spezia: finisce 0-0, anche Pio Esposito sbatte sul portiere blucerchiato
- 19:10 Simeone, lode all'Inter: "Non ha una stella ma tanti giocatori importanti. Mi piace molto, come il Barcellona"
- 18:44 AIA, eletto il nuovo presidente: è Antonio Zappi. Battuta la candidatura di Trentalange
- 18:29 Udinese, Inler: "Sanchez ha sofferto, voleva rientrare. Offerte Bijol? Ora siamo concentrati sul match"
- 18:15 Sky.de - Inter sul talentuoso centrocampista Reitz: tra clausola e pressing del Brighton
- 18:00 Caressa: "Fonseca ha polemizzato dopo Atalanta-Milan senza informare la società, questo non è piaciuto. Manca un leader"
- 17:45 Napoli, Conte: "Siamo all'inizio della costruzione. Sanchez incredibile, gli auguro il meglio"
- 17:30 Atalanta, Gasperini: "Dieci vittorie di fila, ma non cambia niente. Ci sono anche gli altri"
- 17:15 Un 2024 da paura, Thuram coinvolto in 20 gol nella Serie A: nessuno ha fatto meglio di lui. E non è ancora finita...
- 17:00 Serie A, all'Atalanta basta Zaniolo: 1-0 sofferto al Cagliari e balzo a +6 sull'Inter
- 16:45 Bastoni a quota 3 assist in campionato, è già record. Calhanoglu una garanzia contro la Lazio
- 16:30 Atalanta-Inter, Up&Down - Dal vangelo secondo i... Matteo: che partita di Venturini e Spinaccé. Una sola la nota stonata
- 16:15 videoFerri: "Nello sport passione e formazione sono importanti. I genitori devono dare l'esempio"
- 16:00 videoMarotta: "Lo sport è una palestra di vita. Ai giovani dico di divertirvi e crescere per essere gli uomini del domani"
- 15:45 Inter letale in area di rigore, 32 reti segnate: nessuno ha fatto meglio. E Sommer non ha mai subito gol dalla distanza
- 15:30 videoBove al Viola Park, visita ai compagni di squadra. Applausi e sorrisi: il gol più bello di Edoardo
- 15:15 Atalanta, D'Amico: "Pressioni su di noi? Sono motivazioni. Ci faremo trovare pronti per il mercato di gennaio"
- 15:00 Occasione speciale per Lautaro, feeling particolare con la Lazio e l'Olimpico: i numeri
- 14:53 Gara a senso unico ad Alzano: l'Inter U20 fa la voce grossa e stende con un tris l'Atalanta
- 14:45 Fonseca è incontenibile: "Ho parlato con chi volevo parlare. Domani in campo qualcuno di Milan Futuro"
- 14:30 Simone Inzaghi, re delle coppe e del... lunedì: filotto di 5 vittorie consecutive. E contro Baroni non ha mai perso
- 14:15 Lazio-Inter, lunedì all'Olimpico la sfida numero 163 in Serie A: i precedenti. Terza sfida di lunedì nella storia
- 14:00 Assemblea generale AIA, il presidente uscente Pacifici: "Ho fatto errori, ma siamo in ottima salute. Fatevene una ragione"
- 13:45 Assemblea generale AIA, Gravina: "La FIGC ha tutto l’interesse che sia forte e autonoma. Noi al fianco degli arbitri"
- 13:30 Torino, Cairo: "Derby persi con la Juve? Prima del VAR ce ne hanno rubati non pochi. Sul futuro del club..."
- 13:15 Sky - Inzaghi a Roma senza sorprese ma con soluzioni di fantasia. Darmian candidato alla panchina ecco perché
- 12:55 Dopo aver lasciato l'ospedale, Bove corre dai compagni. Il giocatore atteso oggi al Viola Park
- 12:40 GdS - Acerbi, l'Inter riflette: scatterà la risoluzione unilaterale? Intanto De Vrij va alla grande
- 11:57 Un altro premio per Marotta: riconoscimento da parte dell'AIAC Siena
- 11:42 Parolo: "Inzaghi tra i migliori al mondo. Inter, entrare tra le prime 8 di UCL è un dovere"
- 11:27 Marotta: "Inter, famiglia di grandi valori. Non siamo i più bravi, ma i più ambiziosi". Poi l'augurio particolare
- 11:08 Zaccheroni: "Dal 5 maggio a Moratti: bello e appassionante per me che tifavo Inter. Un nome? Stankovic"
- 10:53 TS - Prove anti-Inter per Baroni. L'allenatore della Lazio con un solo vero grande dubbio
- 10:37 TS - La rivalsa dopo Leverkusen. Inzaghi all'Olimpico non vuole errori e punta tutto sulla ThuLa
- 10:23 Peruzzi: "Anno deludente all'Inter, mi fa ridere il gioco dal basso. Calciopoli? Non discuto le sentenze, ma Moggi..."
- 10:06 Dumfries: "All'Inter siamo un bel gruppo. Rissa in Olanda-Argentina? Perdo raramente il controllo, l'ho imparato facendo kick boxing"
- 09:52 Ancora Dumfries: "Raiola uomo dolce. Fin da piccolo avevo un sogno..."
- 09:38 Dumfries: "La chiamata di Ausilio e quel primo giorno particolare ad Appiano. Sulla differenza tra campionato e Champions..."
- 09:24 CdS - Scontri diretti: bilancio insoddisfacente. Inzaghi punta la Lazio
- 09:10 GdS - Difesa obbligata, poi tanti cambi: la probabile di Inzaghi
- 08:56 GdS - Niente da fare: per Bastoni, Dimarco e Barella c'è solo l'Inter. Molteplici no ai tentativi delle big di Premier League
- 08:42 CdS - Inzaghi ne cambia cinque, Dumfries fondamentale: la probabile formazione
- 08:28 Inzaghi: "Vincere è difficile, rivincere di più. Ma ho una convinzione"
- 08:14 Marotta alla festa di Natale: "Vogliamo successi nel rispetto della sostenibilità. Ambizione senza arroganza"
- 08:00 AIA, Zappi punta alla presidenza: "Dialoghi VAR pubblici come nel rugby. E sono favorevole al challenge"
- 00:17 Ventola: "In Champions proverei ad alzare il ritmo schierando i titolari"
- 00:01 Ci vorrà una gara olimpica