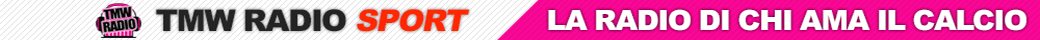Walter Zenga e l'Inter, un matrimonio che non finirà mai. Come cantava Antonello Venditti, "certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano...": ecco, il rapporto tra l'ex miglior portiere del mondo e il club nerazzurro è un po' così. Lo si evince ancora una volta nella bellissima intervista realizzata da Paolo Condò per la Gazzetta, di cui qui vi riportiamo il testo:
È un pomeriggio dell’estate 2002 quando un rappresentante (in carriera) degli aspirapolvere Kirby, passeggiando sul lungomare di Riccione, sente squillare il cellulare. «Sono Gino Iorgulescu. Vuoi allenare il National di Bucarest?».
Cominciamo dal National o dagli aspirapolvere?
«C’è poco da sfottere, come venditore avevo talento. Mi stavo riorganizzando la vita dopo aver realizzato che nei primi 38 anni non avevo capito niente: il calciatore ritiene che tutto gli sia dovuto e soprattutto che durerà per sempre. Errore. Appena smetti c’è chi non ti risponde più al telefono e chi ti frega i soldi che pensavi bene investiti. Comunque sia al mio amico Gino, ex difensore, conosciuto in Sportul-Inter di Uefa nell’84, rispondo "a che ora è il primo volo per Bucarest?"».
Walter Zenga si diverte un mondo a raccontarsi, gesticola allegro lasciando raffreddare gli spaghetti che la moglie Raluca ha appena portato in tavola; siamo sulla spiaggetta privata della sua villa, sulla Palma di Jumeirah.
«È incredibile quello che hanno costruito, questo era mare, siamo 5 chilometri al largo della riva originaria».
Abbiamo fatto interviste in condizioni più disagevoli. Lei aveva già allenato l’ultima squadra nella quale aveva giocato, i New England Revolution di Boston.
«Esperienza formativa, a proposito del non capirci niente. Quando ci vado a giocare non conosco ancora l’inglese, e sull’aiuto di Lalas - ve lo ricordate a Padova? - mi adagio. Quando partiamo per la prima trasferta indico al magazziniere il mio armadietto, "roba okay?" dico, intendendo che se ne occupi lui come succede in Italia. Arrivati a Dallas scopro che in America ciascuno è responsabile del suo materiale: passo la giornata a cercare nei negozi maglia e tuta dei New England, mica facile in Texas».
La panchina gliela propongono subito?
«Sì, ma dico no e torno in Italia. Però la gente si è affezionata, e anch’io un po’: quando mi offrono una partita d’addio volo a Boston, ci sono 42mila persone che applaudono anche se perdiamo 5-1. Mi sono preparato un piccolo discorso, vado sul palco e comincio "I have a dream..."; è la fine, la gente impazzisce, invade il campo per venirmi ad abbracciare. Io non sapevo nulla del discorso di Martin Luther King, bell’ignorante; volevo solo dire che sognavo di tornare spesso a Boston ed essere accolto sempre così. Il presidente mi blocca, "devi firmare, guarda i tifosi come ti amano", io firmo. Un anno di apprendistato in un ambiente magnifico».
Però poi era passato agli aspirapolvere.
«Dovevo capire cosa fare della mia vita. Non per questo smisi di studiare calcio, però. Sono sempre passato per un bambinone, ma è da quando avevo 20 anni che prendevo appunti sui metodi dei miei allenatori, perché nel caso mi fossi deciso volevo essere preparato. In quel periodo ho un vero trip per gli olandesi e soprattutto per il futuro tecnico dell’Under 21, un tipo molto innovativo, Foppe De Haan. Si segni il nome».
Fatto. Adesso siamo nello spogliatoio del National, il primo giorno.
«"Qualcuno parla italiano?". Silenzio. "Qualcuno parla inglese?". Silenzio. Il capitano, Gabriel Caramarin,mi squadra come se fossi un ufo. Dico a Petrescu, che mi ero portato come secondo: "Andiamo in campo e che Dio me la mandi buona". Due ore di lavoro duro ma fatto bene, alla fine Caramarin viene da me e si congratula mescolando un perfetto italiano e un perfetto inglese: "Qui siamo tutti poliglotti, ma prima dovevamo verificare che lei non se la tirasse"».
Ho un nome olandese appuntato sul taccuino.
«Il National partecipa alla coppa Uefa, al sorteggio peschiamo l’Heerenveen. Tutti preoccupati, io guardo alla casella allenatore: Foppe De Haan… È una botta di fortuna pazzesca, so tutto del suo calcio, ho letto i suoi libri e analizzato i suoi dvd. Spiego ai ragazzi cosa succede se la mezzala va a destra, se va a sinistra, se si gratta il naso, quale terzino attacca prima, quale chiude dopo: sul campo si avvera tutto come per magia, 3-0 per noi e mi portano in trionfo, il povero DeHaan mi guarda come se fossi un fenomeno. Al ritorno cambia un paio di cose e non la vediamo mai, ma senza affogare: 2-0, passiamo noi. Quell’anno ci volle il Psg di Ronaldinho per buttarci fuori».
Nel frattempo Walter, un giorno all’aeroporto, in attesa del volo per Bucarest incontra Raluca, splendida studentessa che di calcio non sa nulla ma parla 8 lingue ed è avviata a una carriera da orientalista. Non del tutto il suo tipo.
«La prima volta che torniamo a Milano da fidanzati è domenica, a San Siro c’è l’Inter ma prima che apra bocca lei dice "ho preso i biglietti per la mostra di Modigliani a Palazzo Reale, ci andiamo nel pomeriggio". Fantastico. Lunghe spiegazioni sue davanti a ogni quadro, io orecchio alle mie spalle la gente incredula, "ma quello non è Zenga?", "assomiglia, dai, figurati se Zenga viene qui mentre gioca l’Inter"».
Raluca ride ancora al ricordo: a Dubai cresce Samira, due anni, e in queste ore sta per nascere Walterino, quarto maschio di una dinastia che ha coinvolto altre due mogli.
«Il prossimo obiettivo è una foto con tutti i miei cinque figli. Molto meno semplice di quanto sembri: una foto dei quattro non esiste».
Dal National alla Steaua, e il primo scudetto da tecnico. Ma la storia da raccontare è un’altra, vero?
«Nei sedicesimi di Europa League ci tocca il Valencia di Ranieri, grande squadra, e al Mestalla perdiamo 2-0. "Cosa mi invento adesso?", penso rientrando nello spogliatoio. Trovato. "Ragazzi, da domani ci si allena sui rigori perché andrà a finire così". Rompo talmente tanto le scatole che alla fine ci credono. Morale: vinciamo 2-0, rigori, sbaglia Di Vaio e passiamo noi. Quella notte a Bucarest nessuno ha dormito».
L’anno dopo, complice un inspiegabile esonero a due turni dalla fine (e dal titolo), si va a Belgrado.
«La Stella Rossa è il club più grande che abbia allenato, una società fantastica per la quale ancora oggi mi viene la pelle d’oca, con i giocatori che baciavano la maglia nello spogliatoio prima di entrare in campo, non davanti alle telecamere. Il presidente era Pixie Stojkovic, ora allena in Giappone (Nagoya Grampus, ndr), uomo straordinario. Nel girone di ritorno mi obbliga a girare con due guardie del corpo, stiamo andando troppo bene, la gente del Partizan è furiosa. Il derby di Belgrado è l’esperienza più adrenalinica che esista: i due stadi sono vicini, uniti da un viale che nei giorni di partita è chiuso al traffico, e quando giochiamo in trasferta ci cambiamo nel nostro stadio per trasferirci nel loro dentro a un pullman blindato. Piove di tutto. Riscaldamento, partita e poi subito rientro al nostro Marakana, dove fai la doccia e parli alla stampa. In territorio nemico non si resta un minuto più del necessario».
Perché lasciò la Stella Rossa?
«Per i soldi. Sono nato povero, ho un grande rispetto per il denaro. Mi venne prospettato l’Al Ain, ricco club degli Emirati, che poi invece scelse Iordanescu. Pixie mi attese fino all’ultimo e oltre, ma non sarebbe stato corretto tornare indietro. Dico a Raluca "andiamo in vacanza a Ibiza" e lei risponde "ti chiameranno dalla Turchia". Pazzesco, non c’era stato il minimo contatto, mai. Ho appena disfatto le valigie nell’albergo di Ibiza quando squilla il telefono, è il presidente del Gaziantepspor, al confine con la Siria. Il giorno dopo firmiamo il contratto a Beirut. E io so che mia moglie è una strega».
Com’è Gaziantep?
«Carina, vecchia Anatolia, una stazione sulla Via della seta, mi sento un po’ Marco Polo. Ogni mattina scendo in strada da un anziano carrettiere - tifoso - che ci riserva la frutta migliore. La squadra è quello che è, a un certo punto perdiamo 5 partite di fila, e secondo me un tecnico sconfitto 5 volte di fila ha il dovere morale di presentare le dimissioni. Preparo le valigie prima di andare dal presidente, e quello mi propone un prolungamento del contratto di 2 anni. Mi sento un verme».
Perché? Le dimissioni le aveva presentate...
«Non ha capito, mi sento un verme ancora adesso».
Raluca annuisce vigorosamente.
«A Natale, pausa campionato, veniamo in vacanza qui a Dubai, quelli dell’Al Ain si rifanno vivi e io ci casco. È la cosa più brutta che abbia fatto in vita mia: mollare il presidente Kizil, che nel momento più difficile mi aveva sostenuto... Sto male al solo ripensarci. C’è una giustizia nel fatto che la prima esperienza negli Emirati sia andata male. Me lo sono meritato».
Poi c’è il terzo periodo a Bucarest, alla Dinamo, agosto 2007.
«Società con 5 presidenti in guerra fra loro. Muoversi era complesso. Dopo 4 mesi mi chiamano per esonerarmi e io dico: "Allora sono fuori? Siete sicuri?". La risposta è sì. "Bene, ora che sono fuori vi spiego perché questo club non può andare avanti così". Due ore di rapporto dettagliato, alla fine devo scappare perché non vogliono più esonerarmi: "Lei ha un quadro perfettamente chiaro, non può andarsene così, ci lascia in braghe di tela..."».
Catania e Palermo in due parole.
«La differenza è nei presidenti: Pulvirenti viene in panchina con te, Zamparini non va allo stadio e si fida delle sciocchezze che gli riportano».
E, maggio 2010, siamo tornati in Medio Oriente, primal’Arabia Saudita e adesso ancora Dubai. Dall’Al-Nassr all'Al Nasr, e non è uno scioglilingua.
«Con i sauditi andrebbe tutto bene se solo mi pagassero. Niente, neanche una mensilità: mi muovo secondo i regolamenti, ingiunzione per ricevere gli arretrati, alla fine sono libero e me ne vado. Posso testimoniare che da quando la Fifa si occupa degli stipendi non corrisposti, non esiste più problema: i soldi sono arrivati poco dopo, e ci ho comprato questa villa».
Segno che vuole fermarsi a lungo?
«Il primo anno è andato molto bene. Ho preso l’Al Nasr in zona retrocessione e l’ho portato in Champions League, ora siamo terzi in campionato e abbiamo vinto una partita di coppa su due (oggi 3˚ match con l’Al Ahli saudita, ndr). Stiamo discutendo il rinnovo, io chiedo strutture più professionali. Voglio dire che non solo i giocatori, ma anche il massaggiatore e il magazziniere devono abituarsi a una partita ogni 3 giorni. Sono ottimista, c’è il desiderio reciproco di continuare. Tanto la clausola Inter sarà riproposta come in tutti i miei contratti».
La clausola Inter? È quello che stiamo pensando?
«Non ci vuole molto. Se l’Inter dovesse chiamarmi, sono libero di andare. Mica è un segreto che sogno un giorno di chiudere il cerchio e tornare al mio club per allenarlo. Per arrivarci ho scelto la strada più difficile, in giro per il mondo senza aiuti, imparando a cavarmela e adattandomi ai giocatori che trovavo. Infatti ora so fare tutto, con una preparazione speciale sulle palle inattive, il mio pallino».
Milano le manca anche in questa porzione di paradiso?
«Alcune cose. Alcune persone. Il direttore della banca e l’edicolante, due milanisti con i quali discutere ore».
Sente la rivalità meno di una volta?
«Col Gaziantepspor andiamo a giocare allo stadio di Istanbul, e all’appello l’arbitro si prende una bella arrabbiatura con noi».
Perché?
«Anziché guidare la squadra quel pirla dell’allenatore è in campo a farsi fotografare nella porta in cui il Liverpool, una sera del 2005, segnò tre gol...».
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 00:58 Prima GdS - Belle di Coppa. Roma-Milan da impazzire. Atalanta fai il bis
- 00:47 Prima CdS - CR7 vince la causa: 9,7 milioni dalla Juve. Duro colpo ai conti bianconeri
- 00:34 Prima TS - E Ronaldo intasca altri 9,7 milioni. Ci mancava pure questa
- 00:00 Rimpianto Champions, seconda stella, futuro societario: l'Inter ieri, oggi e domani
- 23:50 André Cruz: "Derby aperto a qualsiasi risultato, mi aspetto uno spettacolo di qualità"
- 23:47 UCL - Sfuma la doppietta per il City, Guardiola eliminato ai rigori: il Real di Ancelotti vola in semifinale
- 23:40 La convinzione di Braglia: "Inzaghi può aprire un ciclo. Cedere Thuram? Un sacrificio importante può starci"
- 23:26 A. Paganin: "Dimarco l'uomo in più dell'Inter. Ha fatto un salto di qualità enorme"
- 23:23 Mondiale per Club, con l'eliminazione dell'Arsenal dalla Champions ecco il Salisburgo
- 23:17 Taremi torna titolare e segna ancora, secondo gol consecutivo: il Porto vola in finale di Coppa
- 23:12 Orsi: "Scuola italiana di portieri resta la migliore al mondo. Di Gregorio forte"
- 22:58 UCL - Il Bayern fa valere l'esperienza: Kimmich piega l'Arsenal, i tedeschi volano in semifinale
- 22:44 Colombo, l'uomo dei derby: dopo Inter-Monza e Inter-Atalanta, ecco la stracittadina milanese
- 22:30 Messina, Jacopo Fumagalli: "Il mio sogno più grande? Voglio giocare a San Siro"
- 22:16 Tensione Lotito-Galliani, il patron della Lazio: "Ti sei schierato con Gravina"
- 22:02 Season Ranking, il Dortmund spinge la Germania: la classifica aggiornata
- 21:48 Cagni: "Gasperini all'Inter fece male, ma resta un grande allenatore"
- 21:34 Handanovic ripensa alle emozioni vissute a San Siro prima di Inter-Cagliari: "Sempre grazie"
- 21:20 Porto-Guimarães, Conceiçao rilancia Taremi: l'iraniano torna titolare dopo 4 mesi
- 21:06 Europeo U-19, Italia nel girone con Irlanda del Nord, Norvegia e Ucraina. Corradi: "Più oneri che onori"
- 20:53 Verona, Lazovic: "Noi motivati dal 2-2 del Cagliari contro l'Inter? No, non guardiamo le altre partite"
- 20:38 GdS - Inter, Ausilio in missione: tappa a Barcellona e Manchester, il ds studia le possibili occasioni di mercato
- 20:24 Milan, Pioli: "PSG e BVB tra le prime 4 d'Europa? Noi siamo gli stessi della semifinale di Champions"
- 20:11 Appiano, l'Inter comincia a mettere il Milan nel mirino: ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di riposo
- 19:57 Milan, il focus di Leao: "Ora abbiamo due partite molto importanti per la nostra stagione"
- 19:43 Prezioso riconoscimento per Zamorano: inserito nella Soccer Hall of Fame del Messico
- 19:28 Caso stipendi, Cristiano Ronaldo vince l'arbitrato: la Juve dovrà dargli 9,5 milioni di arretrati
- 19:14 U-16, l'Italia di Zoratto si aggiudica il Torneo di Sviluppo UEFA: battuto 3-1 il Belgio
- 19:00 Rivivi la diretta! SECONDA STELLA e STORIA, ma NON finisce QUI: dove può ARRIVARE l'INTER di ZHANG. Ospite Tramontana
- 18:52 Damiani: "Conte a Napoli farebbe la differenza. Ma non so se la piazza sia pronta a spendere così tanto"
- 18:37 Gasperini punge la Juve: "Koopmeiners? C’è chi ha tempo per parlare perché non ha le Coppe..."
- 18:23 Sacchi: "Oggi uno si diverte a vedere giocare l'Inter, peccato per la Champions. Inzaghi? Sta cambiando"
- 18:08 Atletico fuori dalla Champions ed è effetto boomerang: ora il 'cagon' sui social è Griezmann
- 17:55 Pavoletti: "Siamo in un ottimo periodo. Felici di affrontare la Juventus, ce la giocheremo fino all'ultimo"
- 17:40 Borghi: "Inter più forte di Atletico Madrid e BVB a livello assoluto, il rammarico per la Champions c'è"
- 17:26 Stagione finita per Ferguson, l'abbraccio di Arnautovic: "Tornerai più forte di prima"
- 17:13 Milan tra Europa League e derby, De Rossi: "Domani vivranno la partita come un'ultima spiaggia"
- 16:58 Denis: "Lautaro il miglior attaccante della Serie A. Ma ce n'è uno che mi somiglia molto"
- 16:44 Onazi: "Tra Pioli e Inzaghi, preferisco l'interista. Il suo futuro? Potrebbe andare ovunque"
- 16:29 Atletico Madrid ko ma al Mondiale per Club, Simeone: "Bene per la società, a me interessa poco"
- 16:15 Trevisani: "Carboni raggiungerà livelli altissimi. Forse non all'Inter, ma in una squadra medio-alta sarebbe un crack"
- 16:00 Frey: "L'Inter è tornata ad essere protagonista assoluta. Per lo scudetto Lautaro dovrà aprire un Negramaro"
- 15:46 Udinese, Perez: "Con l'Inter avuto il giusto atteggiamento. Argentina? Ecco cosa mi consiglia Samuel"
- 15:31 Malesani: "Per lo Scudetto serve anche un ambiente che condizioni avversari e arbitri"
- 15:17 Satin: "Difficile che il PSG ripensi a Thuram per il dopo Mbappé"
- 15:03 Valentini alla Bombonera, tifosi del Boca Juniors divisi tra contestazione e autografi: la replica del difensore
- 14:49 Mundial de Clubes 2025, nuova qualificata dall'Asia: la FIFA dà il benvenuto all'Ulsan HD
- 14:35 Galante: "La seconda stella nel derby sarebbe fantastica, ma l'importante è vincere un titolo meritatissimo"
- 14:22 Padova, suggestione amichevole con l'Inter prima dei playoff di C. Ma c'è un problema
- 14:07 Ranieri torna sul 2-2 di San Siro: "Il tocco di Lapadula? Tre anni fa avrebbero annullato il gol"
- 13:53 Il futuro del campionato con Football Manager: sarà dominio Inter, con tabù Champions. Dopo Inzaghi...
- 13:38 Ranking UEFA per club, l'Inter mantiene la sesta posizione. Balzo del Paris Saint-Germain
- 13:24 Mondiale per Club 2025, un'altra qualificata dopo i quarti in Champions di ieri
- 13:10 Prima del derby sul campo, quello della solidarietà: le curve di Inter e Milan insieme per i City Angels
- 12:56 Inter e Highsnobiety insieme per la Milano Design Week 2024: lanciata una nuova capsule Collection
- 12:42 L'analisi di Ravanelli: "L'Atletico si è sgretolato, c'è rammarico per i tifosi dell'Inter"
- 12:28 Premio Alberoandronico, riconoscimento per il preparatore atletico dell'Inter Fabio Ripert
- 12:13 Serie A, arbitri 33a giornata: il derby Milan-Inter sarà diretto da Colombo di Como, in sala VAR ci sarà Marini
- 12:00 ADDIO OAKTREE e NUOVO PRESTITO: ZHANG si TIENE l'INTER! Novità FESTA SCUDETTO: SUPER CONCERTO e INNO
- 11:45 Il Boca Jrs. batte il Godoy Cruz in Copa de la Liga: Valentini fa il tifo dai palchi della Bombonera
- 11:30 GdS - Nessuno come Milano nei top campionati. Ma il Milan deve rimontare in Champions
- 11:16 TS - Stadio a Rozzano, si va verso la proroga della prelazione fino a fine 2024
- 11:02 TS - Gudmundsson, ci sono anche Juve e Tottenham. I bianconeri ci provano con le contropartite
- 10:48 Viola: "Il 3-2 all'Inter sarebbe stata l'apoteosi, ma in quell'azione..."
- 10:34 TS - Derby, oggi la ripresa: un solo dubbio di formazione. E col Toro si va già verso il sold out
- 10:20 Zambrotta: "Inter troppo forte, merita lo scudetto. Trionfo nel derby? Il Milan avrà motivazioni altissime"
- 10:06 TS - Cuadrado, rush finale con una convinzione. C'è un retroscena con un tifoso
- 09:52 Il Sole 24 Ore - Zhang ha trovato la soluzione per tenersi l'Inter: tre nomi per il nuovo finanziatore
- 09:38 TS - Inzaghi, c'è una richiesta oltre al rinnovo. Tre giocatori nel mirino: serve reperire 60-70 milioni
- 09:24 CdS - Frattesi certezza dell'Inter: decisivo anche dalla panchina